Iacopo Gardelli ci parla del suo primo romanzo, “L’Alsìr”, un incrocio di vite in riva all’Adriatico per una generazione alla fine del mondo
Più informazioni su

Iacopo Gardelli è nato nel 1990 a Ravenna, dove vive e lavora. Dopo una laurea in filosofia si è dedicato alla scrittura, al teatro, al giornalismo e all’insegnamento. Collabora con quotidiani locali e riviste. Ha scritto articoli, spettacoli e monologhi teatrali. Questo è il suo primo romanzo. Così si presenta Iacopo sul retro di copertina de “L’Alsìr. Romanzo balneare” (edito da Fernandel) che esce domani nelle librerie e negli store online. Ma lui per me è più di questo. È un amico. E mi è impossibile dargli del ‘lei’. Mi scuseranno i lettori nel corso dell’intervista.
“L’Alsìr” è il suo primo romanzo, lo dice lui, ma certamente non è il primo testo importante. Ne ha scritti altri. Per il teatro. Oltre a “La città sfinge. Rilettura in tre atti della novella di Nastagio”, un colto e squisito divertissement che tradisce a 24 anni una sorprendente maturità narrativa, ma che il nostro a distanza di anni sembra ingiustamente disconoscere. Per chi volesse riscoprirlo, lo ha pubblicato Ivan Simonini con le Edizioni del Girasole nel 2014.
Ma ora siamo all’ultima storia, con un titolo dal suono esotico ed evocativo. Pregno di romagnolità. Dove tutto – ma sarebbe meglio dire tutto e niente, perché estate dopo estate il mondo sembra rotolare via all’Alsìr senza che nulla veramente accada – si svolge in riva all’Adriatico, per quello strano rapporto che molti ravennati hanno con il loro mare. Imprescindibile e assediato d’estate. Semiabbandonato e snobbato d’inverno. Un romanzo balneare? Sembrerebbe di sì. Ma opterei per il no, perché non so cosa voglia dire esattamente ‘balneare’ e non lo voglio sapere. L’Alsìr è molto di più: una storia senza tempo e fuori dallo spazio. Come sono tutte le storie universali che raccontano la condizione umana, che a ogni generazione si rinnova e in ogni persona s’incarna. Fino alla fine del mondo.

L’INTERVISTA
Cominciamo dal titolo. Dammi la tua traduzione di alsìr. Da vecchio romagnolo, ricordo solo che mia madre ogni tanto usava questa parola, peraltro sempre in negativo. A me suonava e suona come un qualcosa che sta a metà strada fra il tempo, la voglia, il desiderio, l’agio di fare o non fare qualcosa. Qual è la tua interpretazione?
“Ho incontrato il termine alsìr durante gli studi che ho fatto, potremmo dire lessicografici. Per scrivere il romanzo ho letto molte cose sulla lingua di Romagna, tra cui il classico vocabolario di Libero Ercolani pubblicato dalle Edizioni del Girasole. Dovevo farmi una lingua. Io non sono dialettofono. Il dialetto lo so capire certe volte, magari con difficoltà, sicuramente non lo so parlare, tanto meno so scriverlo. Quindi ho studiato. Leggendo l’Ercolani, subito mi sono imbattuto in questa parola che mi ha affascinato per il suo suono orientale. Non è un suono particolarmente italiano, no!? Vuoi anche per il significato, cioè agio, esattamente quello che hai detto tu. Cosa significa agio se non tempo libero, ozio? E in più viene utilizzato quasi sempre in negativo in dialetto. La radice latina del termine è licere che poi ritroviamo nel loisir francese, che significa la stessa cosa di alsìr. Quando ho incontrato questa parola, mi sono detto: il bagno deve chiamarsi così. Mi sembrava perfetto, evocativo, strano, se vuoi esotico.”
Ecco, la tua scrittura, la tua lingua. Parliamone. Nella presentazione la si definisce meticcia. Molte parole sono mutuate dal dialetto, oppure torte, adattate, storpiate, alcune secondo me te le sei completamente inventate, anche perché in certi casi mi sono scervellato per capire che cosa voleva dire quel termine o quell’altro. Sono tutte parole che hanno uno spiccato tratto onomatopeico. Insomma con il suono della parola vuoi evocare un oggetto, un gesto, una situazione, un sentimento, qualcosa. Però inventarsi una lingua al primo romanzo è molto ambizioso e alla fine c’è un verso di Nevio Spadoni che richiama proprio questa operazione. Spiegami di più.
“Qui si aprono varie questioni. Hai citato Spadoni, ma in esergo c’è un’altra citazione a cui tengo molto: quella di Ignazio Buttitta, poeta siciliano del secondo Novecento. In una sua bellissima poesia dice: “il popolo diventa povero e servo quando ci rubano la lingua, quando le parole non figliano parole”. Ho trovato che in questo verso di Buttitta ci fossero un po’ tutte le ragioni per cui ho scelto di fare questo lavoro linguistico che, come dici tu, è ambizioso ed è stato sicuramente l’aspetto più gravoso della scrittura del romanzo. Il linguaggio ci serve per parlare del mondo. Se semplifichiamo il linguaggio semplifichiamo il nostro modo di vedere il mondo.”
Le parole sono importanti, direbbe Nanni Moretti.
“Sì. Quello che sta succedendo, diciamo negli ultimi 20-30 anni, soprattutto nell’italiano editoriale, va nella direzione di una continua semplificazione del lessico ad uso del lettore, di cui capisco le ragioni – serve per vendere il libro e per farsi capire – ma con l’effetto collaterale di semplificare il nostro modo di parlare e di vedere le cose. Se andiamo a prendere i libri scritti dai grandi maestri del passato, diciamo dalla seconda guerra mondiale in poi, insomma, del secondo Novecento, notiamo che c’era sempre uno studio approfondito, non solo della trama, dell’intreccio, della sociologia, ma anche del linguaggio stesso. Non c’è bisogno di scomodare per forza Gadda o D’Arrigo. O il Pasolini di Ragazzi di vita. Quelli aumentavano a dismisura la complessità del linguaggio, magari spesso anche in modo respingente. Molte persone mi dicono che non riescono a leggere Gadda perché è complessissimo e hanno perfettamente ragione. Ma se noi prendiamo ad esempio Fenoglio, lui scrive in un impasto di italiano e piemontese; oppure possiamo prendere Natalia Ginzburg che inizia il Lessico famigliare – non a caso si chiama così il libro – con “non fate potacci, non fate sbrodeghezzi”, che sono parole dell’intimità familiare. C’era un discorso profondo e complesso sul linguaggio. È ciò che mi affascina di più. Quindi mi sono detto: se voglio scrivere qualcosa secondo la mia sensibilità devo fare un lavoro di costruzione del mio linguaggio.”
Insomma, la costruzione di un lessico italianizzando il dialetto o romagnolizzando l’italiano.
“Da quanto tempo si dice che il dialetto sta morendo, che il dialetto morirà… anche Nino Pedretti lo diceva, in una poesia che rispondeva proprio a quella di Buttitta e che finiva così: “se la lingua muore il paese è andato, non ha più storia”. Ecco, il dialetto lo stiamo perdendo e lo perderemo probabilmente nel giro di due generazioni. Credo che fare qualcosa per salvare la ricchezza di una lingua passi oggi soprattutto dall’allargare le maglie dell’italiano.”
Romanzo balneare o piuttosto romanzo esistenzialista, percorso da una vena di profonda malinconia e di pessimismo sulla condizione umana. La Romagna è qui in fondo un pretesto familiare e autobiografico ma L’Alsìr potrebbe essere ambientato in qualsiasi altro luogo in riferimento a questa dimensione esistenzialista e pessimista. Quindi questa ha l’ambizione di essere una storia universale. O sbaglio?
“Ogni lettura di un romanzo è giusta in un qualche modo. Sempre per parlare per citazioni, Enzensberger dice una cosa fulminante sull’arte, ovvero che “ogni opera è un torso le cui membra giacciono nel futuro”. Immagina la Nike di Samotracia, ma le sue parti mancanti non sono perse nel passato, sono ancora da scolpire. Sono cioè i futuri lettori che cambiano e completano un libro. Tu utilizzi l’aggettivo universale, è una parola molto impegnativa, mi piace e mi lusinga. In realtà volevo scrivere una storia che non potesse essere ambientata in un altro luogo e in un altro tempo. Per questa ragione ci sono così tante descrizioni del luogo, dell’ambiente circostante, a partire dalla valle arrivando alla riviera e al porto. C’è anche la variabile tempo: la storia non poteva essere ambientata in un altro tempo. Il mio punto di partenza non era tanto di renderla una storia universale, anche se si parla di cose che tutti viviamo, c’è un amore che finisce, un’amicizia che si rovina, ci sono problemi economici, un matrimonio fallito, ci sono diciamo dei luoghi letterari. La questione centrale era soprattutto scrivere qualcosa di sincero. Secondo me ogni romanzo deve essere anche un atto di conoscenza e quindi non può non partire dall’ambiente in cui sei cresciuto, sei vissuto, hai fatto le tue esperienze di vita. Che ti servono per dare corpo alla tua storia, quale che sia.”
E va bene, Ravenna non è un pretesto e non volevi raccontare una storia universale. Come Bassani racconta di Ferrara, tu racconti di Ravenna, ma attraverso un unico luogo fondamentalmente. Tutto è ricondotto quasi ad un’unità di luogo, l’Alsìr, il bagno, come fosse una quinta teatrale. C’è una Ravenna né bella né brutta, tantomeno vitale anche se gioca a racchettone, è una Ravenna quasi esotica, piuttosto sudaticcia, annoiata, sfibrata, stracca, perduta… dove in fondo non succede mai veramente nulla di importante e dove i protagonisti si dimenano con le loro vite all’interno di microstorie ai margini della grande storia, della storia tragica. È così allora che vedi Ravenna e i tuoi protagonisti?
“Mi piace molto il termine che utilizzi. Cioè mi piace l’idea che l’Alsìr sia ai margini, perché alla fine è ciò che rappresenta la riviera rispetto a noi ravennati. È comunque un posto distante, che vive in modo schizofrenico. Ci andiamo l’estate, lo viviamo con la bella stagione. E sbottiamo perché non troviamo parcheggio, perché c’è casino. Poi d’inverno ce lo dimentichiamo. A me questa dimensione schizofrenica di vicinanza, ma allo stesso tempo di grande distanza mi ha sempre affascinato. Il nostro modo di intendere il mare è diverso, se ci pensi, dal modo di intendere il mare di una Rimini, che ce l’ha lì per tutto il tempo, oppure di quelli dall’altra parte, sulla costa tirrenica. Sì, è vero, è un luogo che sta ai margini delle nostre vite, ma che in certi momenti è importantissimo. Ravenna è sempre sullo sfondo, non viene mai citata nel libro in realtà. Cioè non c’è la parola, Ravenna. Bassani invece ambientava i suoi meravigliosi racconti proprio all’interno delle mura. Parlo del porto di Ravenna, della valle, qualcosa che gravita sempre attorno a quell’incontro di mare e di terra.”

Ma che mi dici del vivere dei protagonisti ai margini della grande storia?
“Qui faccio ancora più fatica a risponderti. Il romanzo parte nel 1994, con Berlusconi e l’inizio della Seconda Repubblica, e finisce nel 2012, nel pieno della grande Recessione. Ho individuato questo periodo di tempo come se avesse un’unità. Nella mia testa, è questo. Che è stato poi il tempo della mia formazione personale, con l’uscita dall’infanzia e l’ingresso nella maturità. Non è che loro, i protagonisti, vivano ai margini della storia, forse più semplicemente la subiscono. Cioè ci sono delle trasformazioni che tutti i personaggi vivono in modo quasi inconsapevole e che finiscono per cambiarli tantissimo. Cambia tantissimo Ivan, che parte da un’identità politica ben definita per poi arrivare alla disillusione e al qualunquismo o, pare, ai grillini. Così come cambia Guido, cambia Elena. In modo inconsapevole la storia li attraversa, esattamente come succede per noi, durante le nostre vite. Sappiamo di essere immersi nella storia, ma quasi sempre non ne siamo protagonisti, la subiamo.”
La Natura e il Meteo hanno un ruolo importante nel racconto. Alcune descrizioni sono fra le più poetiche, potenti ed accurate. Quasi che deluso dalle persone ti rifugiassi negli elementi. E comunque nemmeno la natura e gli elementi hanno una dimensione veramente tragica o gloriosa. È una natura anch’essa trattenuta, come ingavagnata dagli uomini, che di tanto in tanto si sfoga e che soprattutto finisce per dare tormento. Il caldo, l’afa, il buldezzo, il vento, la mucillagine, il temporale, l’incendio, l’alba col suo freddo. Una natura quasi da terzo mondo, senza la potenza primitiva del terzo mondo, tutto sommato svigorita come è il nostro primo mondo. È una natura che sottolinea e accompagna queste esistenze ai margini e in attesa, di cui parlavo prima.
“Ti ringrazio molto per questo rilievo, perché ho lavorato tanto per riuscire a descrivere la natura in quel modo lì, ho studiato anche manuali di botanica, per dirti, perché volevo sapere quali erano le specie di piante nella valle oppure le piante psammofite che vivono nella sabbia delle nostre dune, che hanno dei nomi bellissimi. Ad esempio la sgarza, che è quell’erba palustre tagliente che si usava per impagliare i cesti, o lo sparto, che pizzica i piedi sulle dune. C’è stato molto lavoro, anche se vuoi di ricostruzione di un lessico botanico. Ho sempre avuto l’impressione che la natura della spiaggia vivesse sotto il segno della domesticazione. Cioè come se i romagnoli avessero voluto addomesticare e quindi normare un luogo come la spiaggia.”
L’abbiamo imbrigliata, ingavagnata.
“L’abbiamo ingavagnata di filari di ombrelloni, come le nostre campagne sono state normalizzate con i filari di vite. Perché la spiaggia di per sé è un luogo senza ombra, respingente, cioè non ci vivremmo volentieri. Allora ci abbiamo messo gli ombrelloni. Quindi questa natura è fortemente antropizzata. Che cosa sono i bagni se non dei condomini in riva al mare?! Però ogni tanto la natura si prende la rivincita con il buldezzo, con la mucillagine che respinge, oppure se vuoi con quelle tempeste di sabbia che certe volte vengono ad agosto e fanno dannare, quindi sì, è una natura che noi continuiamo a pensare come piacevole, rilassante per le nostre vacanze, ma è comunque natura e certe volte sfugge al nostro controllo, si rivolta. E se ci pensi, nell’ultimo capitolo del libro, che è un capitolo di sogno, alla fine c’è una natura che riprende il sopravvento.”
Veniamo al protagonista, il giovane Guido, che ha alcuni tratti autobiografici. Lo vediamo crescere sulla spiaggia dell’Alsìr e dintorni dai 4 anni all’età in cui è ormai adulto: si potrebbe definire un racconto di formazione… se tutto ruotasse davvero attorno a lui, ma non è così. Lui è appena un po’ sopra agli altri ma nessuno emerge veramente e nessuno è il perno del romanzo. Come se non ci fosse un centro, e un centro non dovesse esserci, ma tutto dovesse rimanere corale e a un tempo sospeso e irrisolto, come Guido, che fino alla fine non sa qual è la sua strada se non la lettura, come l’Alsìr, come Ravenna, come l’estate. Si potrebbe dire come la vita.
“Sempre delle domande belle e semplici. Comunque hai perfettamente ragione. Io volevo creare un romanzo corale, un romanzo dove non ci fosse il protagonista, l’eroe con le sue peripezie fino ad arrivare allo scioglimento. Cioè volevo disarticolare un po’ questo modo stereotipato di scrivere.”
Non ci hai messo neanche un delitto.
“Bravissimo, mi fa piacere che l’hai colto (ride, ndr). No, qui non ci sono delitti. Qui non ci sono crimini, commissari e indagini, non ci sono pretesti di genere, con tutto il rispetto per opere di genere che io non sarei affatto in grado di scrivere. Questo è un romanzo corale dove ogni protagonista vuole essere protagonista a tutto tondo, con una psicologia convincente. Sai quel vecchio adagio che dice: quando uno scrittore scrive a un certo punto i protagonisti prendono loro il sopravvento e tu li devi seguire. In un certo senso in alcuni momenti è stato così. Non con tutti i personaggi ma per alcuni è stato così. Forse per quelli a cui inconsapevolmente ero più legato. Ma si può dire che sono legato praticamente a tutti i protagonisti di cui ho parlato.”
Allora prendiamo le tre donne. Teresa e Caterina, le due mamme, a me ricordano due Madame Bovary di diversa condizione sociale ma della stessa impronta psicologica. Sono vagamente deluse, insoddisfatte e guardano chi sta più in alto. Caterina guarda Teresa e pensa addirittura al di lei marito. Teresa guarda a donne più in alto di lei e pensa a cosa sarebbe potuta diventare se non avesse sposato Berto. Poi c’è la giovane Elena, annoiata, apatica, indifferente, che si lascia vivere senza entusiasmi. Nessuna delle tre figure femminile esce bene da queste storie: le donne non salvano il mondo?
“Nessuno salva il mondo, certo (ride, ndr). Allora partiamo da Elena che è un po’ il motore di tutto.”
Perché è l’oggetto del desiderio ed è il personaggio più enigmatico.
“Esatto. Con Elena volevo raccontare veramente quella che è stata la più grande caratteristica della mia generazione, che tu definisci come l’essere irrisolti, l’indecisione. Io trovo che sia un carattere profondamente radicato nella mia generazione, e forse è dipeso dal fatto di avere avuto noi troppa libertà. Mi spiego meglio. Elena lo dice a un certo punto: “ci dicono che possiamo essere tutto, allora significa che non siamo niente”. Io ne conosco tante di persone che avendo la possibilità di fare quello che volevano si sono perse, sono rimaste paradossalmente ingabbiate e non hanno saputo cosa fare. Elena si perde nella sua libertà – dice il narratore – come se si perdesse in un deserto, non sa dove andare, non si è guadagnata niente e quindi per niente ha sentito furore, voglia, desiderio. Elena è irrisolta, così come sono irrisolto io.”
E le due mamme?
“Le altre due tu dici che non escono bene. Io ho cercato di fare in modo che nessun personaggio – esattamente come nella vita normale – fosse bianco o nero. Sono tutti personaggi grigi, fatti di sfumature, che si possono comportare male, ma che hanno ragioni profonde per farlo. Caterina e Teresa sono due modi complementari di intendere la maternità, laddove Teresa ha vissuto la maternità come una limitazione, mentre invece Caterina no. Non voglio svelare troppo, ma forse Caterina riesce, nella sua semplicità, a trovare uno spazio, un respiro di libertà anche in quel ruolo in cui si è trovata a vivere, così come ci si sono trovate molte donne. Ma non voglio fare discorsi femministi senza patente.”
Ivan è un uomo deluso dalla politica e dalla vita, un po’ incattivito e ormai vinto. Berto è l’uomo arrivato, saggio, riservato, ma ripiegato su se stesso e vive ai margini del piccolo mondo dell’Alsìr fino al capitolo finale. Il suo essere positivo non s’irraggia. Alessandro è un vitalista vitellone che esercita attrazione su Guido, solo finché Guido non decide di crescere. Anche questi tre non ne escono bene.
“Sì, i maschi… Mi sono molto divertito a scrivere di questi personaggi perché c’è sicuramente molto di autobiografico, c’è qualche personaggio che ho conosciuto, rivisto e rivisitato. Partiamo da Berto. È l’uomo saggio ma è molto bello quello che dici tu, cioè che la sua saggezza non si irraggia.”
Beh, tranne in un caso: nella corrispondenza da lontano con Guido. Poi mi dirai cosa rappresenta Moby Dick.
“Umberto è fin dall’inizio un individualista, questo lo si capisce molto bene. È uno che si fa gli affari suoi, ha un’idea molto personale ed epicurea della vita. La sua filosofia emerge chiaramente nella cena insieme ai Montanari, quando cita Voltaire: bisogna coltivare il proprio giardino. Umberto è uno che ha deciso di staccarsi dalla vita attiva, o forse non ne ha mai fatto parte. Rappresenta il vivere per la bellezza, per le piccole cose belle che ti dà la vita. Diventa una sorta di padre vicario per Guido, che ritrova in lui tutta una serie di qualità che non vede in suo padre. Questi sono rapporti e vicende psicologiche che secondo me nell’adolescenza accadono spessissimo.”
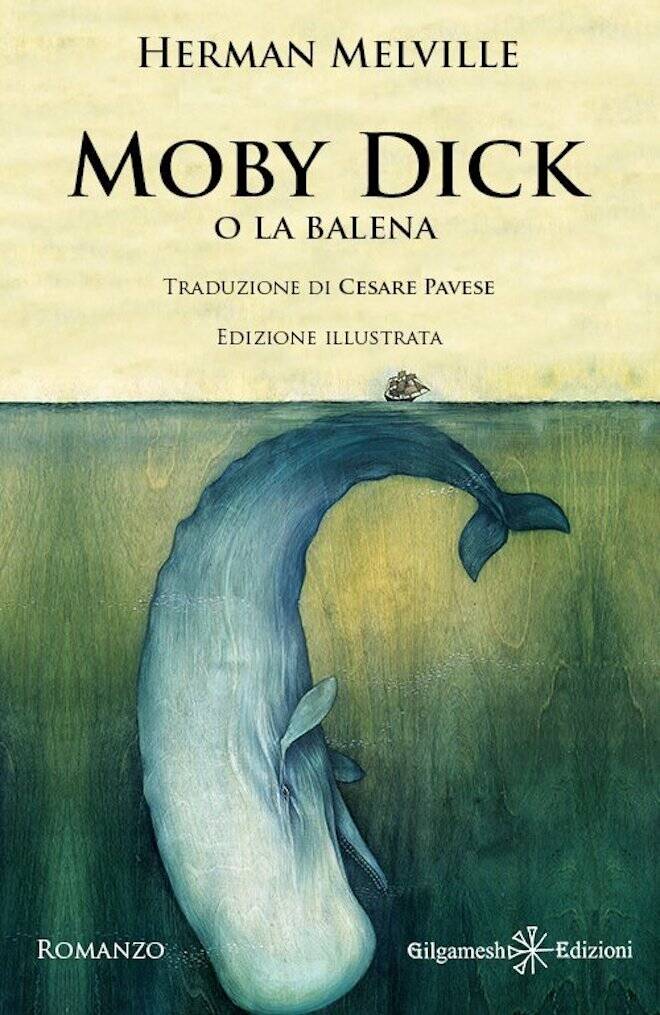
Sono fili molto sottili, vicende accennate con garbo.
“Ecco, questo è un bel complimento che mi fai. Mi viene in mente una frase bellissima di Flaubert che dice: “in ogni cosa c’è un punto di ignoto”. Ecco, anche in questi rapporti così semplici, così quotidiani, si può scavare per trovare delle cose che non sappiamo, anche di noi stessi. In definitiva, si può dire che ognuno di questi personaggi rappresenta alla sua maniera un modo per scampare alle piccole disperazioni della vita.”
In definitiva l’umanità e la vita per Iacopo Gardelli sono così deludenti come appaiono e privi di speranza? Anche nel contrasto fra generazioni, la speranza e il desiderio sembrano spegnersi e non si trasmettono, come direbbe Recalcati. Oppure da qualche parte c’è un barlume di speranza in tutta la bellezza che evoca Berto, sul finire della vicenda e dell’Alsìr?
“Domandone. La letteratura non deve dare speranza. Se dà speranza sta mentendo al lettore e la lettura non è un lenitivo. La speranza di cui mi parli appartiene forse a un’altra generazione, diversa dalla mia. Voi siete cresciuti con il mito delle magnifiche sorti e progressive dell’umanità, con la rivoluzione, Marx e il sol dell’avvenire.”
E siamo finiti con la Meloni.
“Già. Adesso stiamo vivendo un’altra fase storica e culturale che potremmo definire del millenarismo. Siamo sempre più ossessionati dalla fine del mondo, dal finire delle cose, non da un nuovo inizio. Parliamo spessissimo di ecologia, del pianeta che muore, della guerra. Questo libro rispecchia questo clima culturale. Parlare di speranza e di progresso sarebbe stata una falsificazione. Tuttavia quell’ultimo capitolo che cos’è se non l’apertura – e Spadoni dice “si apre un libro in una lingua nuova” – l’apertura su qualcosa di ignoto?! Io credo veramente che stiamo vivendo una fase in cui siamo sulla soglia di qualcosa di diverso, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista politico. E il sogno finale parla di questo: uso il termine “palingenesi”, cioè nuova nascita, nuovo inizio. Se poi questo inizio porterà qualcosa di positivo o qualcosa di negativo questo io non lo so. Non condivido invece quello che dici sul pessimismo. Non credo sia un libro intrinsecamente pessimista. Non credo che la vita sia male: ha delle contraddizioni e i personaggi vivono immersi in queste contraddizioni.”
Moby Dick di Melville per finire.
“È il simbolo di un passaggio di testimone. A che cosa serve il rapporto fra generazioni se non per prepararsi, se non per trasmettere qualcosa?! Forse Moby Dick simboleggia proprio questo e dico forse perché un autore non è cosciente al cento per cento di quello che ha scritto. Quel libro è stato importantissimo nella mia formazione, è un libro che ha lasciato una traccia e mi ha fatto capire che questa cosa mi piaceva, mi appassionava. E mi piace quel piccolo indovinello che fa Berto dando il libro a Guido: me lo ridarai solamente quando mi saprai dire qual è la gamba di legno di Achab… lui non l’ha ancora finito quindi non lo può sapere. Ma mi fermo qui. E se anche il lettore vuole saperlo, andrà a rileggersi Moby Dick.”








